Introduzione
La nascita di Demoskopea
Gli anni sessanta
Gli anni settanta
Gli anni ottanta
Conclusioni
Bibliografia di riferimento
Introduzione
Il presente articolo dà conto di una ricerca - in corso di svolgimento – la cui prima ambizione è ricostruire, attraverso la storia della società Demoskopea, i percorsi che hanno caratterizzato la seconda generazione di istituti d’opinione italiani, indagandone obiettivi, motivazioni e metodi di lavoro, anche a partire dalle differenze che essi andavano marcando dalla capostipite tra le imprese del settore, la Doxa di Pierpaolo Luzzatto Fegiz.
Le brevi note metodologiche che seguono, così come i contenuti esposti nell’articolo, derivano dallo scambio continuo di riflessioni con Giuseppe Paletta, Direttore del Centro per la cultura d’impresa di Milano; il suo consiglio esperto, in tutte le fasi dell’indagine condotta finora, è stato per chi scrive il principale sprone alla ricerca .
.
Quanto esposto di seguito rappresenta forse una dimostrazione di come chi compia ricerca storica sull’impresa – e in particolar modo sulle società di dimensione media o piccola – debba assumersi dei rischi. Si tratta, pensiamo, di non farsi fermare dall’assenza di un archivio già costituito, soprattutto quando, come nel caso qui analizzato, la raccolta di testimonianze in profondità (sulla scorta anche di una consolidata letteratura metodologica sulle fonti orali) permette di far emergere, gradualmente, anche la documentazione – le carte – che gli intervistati hanno conservato nel tempo (in questo caso, anche a distanza di anni dall’interruzione del rapporto con Demoskopea)
permette di far emergere, gradualmente, anche la documentazione – le carte – che gli intervistati hanno conservato nel tempo (in questo caso, anche a distanza di anni dall’interruzione del rapporto con Demoskopea) . Del resto l’impresa, "punto di coagulo di una memoria prodotta in modo cooperativo da un insieme di attori economici"
. Del resto l’impresa, "punto di coagulo di una memoria prodotta in modo cooperativo da un insieme di attori economici" lascia tracce della propria storia attraverso l’azione plurale di tutti coloro hanno contribuito a farla esistere
lascia tracce della propria storia attraverso l’azione plurale di tutti coloro hanno contribuito a farla esistere ; e – elemento forse ancora più importante – allo stesso modo definisce la propria identità nel presente: motivo per cui la memoria ha ricadute organizzative che gli imprenditori, crediamo, non dovrebbero trascurare.
; e – elemento forse ancora più importante – allo stesso modo definisce la propria identità nel presente: motivo per cui la memoria ha ricadute organizzative che gli imprenditori, crediamo, non dovrebbero trascurare.
L’articolo che presentiamo al lettore può dunque creare, relativamente alla storia di Demoskopea, una ulteriore pista informativa, favorendo un ulteriore ciclo di testimonianze sia di quanti già lo hanno fatto, sia di chi si senta sollecitato dalla lettura. Inoltre la documentazione cartacea – ricerche, riviste aziendali, documenti - che è andata organizzandosi durante le interviste (grazie appunto ai testimoni), potrebbe ulteriormente arricchirsi, permettendo la ricostituzione di un archivio.
Il testo che presentiamo non è solo il frutto del ricordo orale e dei documenti citati; chi scrive ha potuto riferirsi all’indispensabile archivio dell’anagrafe imprese presso la Camera di Commercio di Milano, necessaria alla ricostruzione delle fasi di  vita della Demoskopea a partire dalla sua fondazione nel 1965 (l’obiettivo di questo articolo – esposto sopra - e le esigenze di brevità rimandano ad altri scritti, da realizzarsi, la descrizione puntuale di tutti i passaggi istituzionali che hanno visto e vedono tuttora protagonista questa impresa).
vita della Demoskopea a partire dalla sua fondazione nel 1965 (l’obiettivo di questo articolo – esposto sopra - e le esigenze di brevità rimandano ad altri scritti, da realizzarsi, la descrizione puntuale di tutti i passaggi istituzionali che hanno visto e vedono tuttora protagonista questa impresa).
La nascita di Demoskopea
|
 |
La costituzione di Demoskopea, nel luglio del 1965, rappresenta l’inizio di una nuova fase nel panorama – assai giovane e finora poco studiato – delle società italiane di indagine sociale e di mercato. Negli anni  del "miracolo economico" si assiste infatti a quella che Sandro Rinauro ha definito "la nascita della seconda generazione di istituti d’opinione italiani"
del "miracolo economico" si assiste infatti a quella che Sandro Rinauro ha definito "la nascita della seconda generazione di istituti d’opinione italiani" , processo caratterizzato dalla progressiva diffusione delle indagini di mercato e, al contempo, dalla radicale innovazione delle stesse, sia sul versante metodologico, sia sul piano delle strategie (mercati di riferimento, committenti, tipo di sguardo sulla società in tumultuosa trasformazione).
, processo caratterizzato dalla progressiva diffusione delle indagini di mercato e, al contempo, dalla radicale innovazione delle stesse, sia sul versante metodologico, sia sul piano delle strategie (mercati di riferimento, committenti, tipo di sguardo sulla società in tumultuosa trasformazione).
Giampaolo Fabris e Carlo Erminero decidono di dar vita a Demoskopea – insieme a Bartolo Mardesich, Mario Gola, Tullio Bonaretti, Rossana Locatelli, Nedda Penne-, stabilendone la sede in Via Podgora a Milano. Fabris ha già maturato un’esperienza nella Attwood  (società inglese successivamente assorbita dalla stessa Demoskopea) e soprattutto nella Doxa di Pierpaolo Luzzatto Fegiz, l’uomo che nel 1946 aveva introdotto in Italia le ricerche d’opinione.
(società inglese successivamente assorbita dalla stessa Demoskopea) e soprattutto nella Doxa di Pierpaolo Luzzatto Fegiz, l’uomo che nel 1946 aveva introdotto in Italia le ricerche d’opinione. Può inoltre contare sugli insegnamenti del suo relatore presso l’Università di Pisa, lo statistico Guglielmo Tagliacarne, autore nel 1951 – con Luzatto Fegiz e George Gallup -, del primo manuale italiano di sondaggi di mercato.
Può inoltre contare sugli insegnamenti del suo relatore presso l’Università di Pisa, lo statistico Guglielmo Tagliacarne, autore nel 1951 – con Luzatto Fegiz e George Gallup -, del primo manuale italiano di sondaggi di mercato.
Anche Carlo Erminero, che insieme a Fabris costituisce la direzione strategica di Demoskopea - occupandosi prevalentemente di metodologia della ricerca quantitativa, e delle sue applicazioni allo studio del mercato editoriale e pubblicitario - proviene da Doxa e intende marcare da essa una differenza metodologica accompagnata dalla ricerca di un nuovo target di committenti.
La tesi di laurea di Giampaolo Fabris, Prospettive e limiti dell’applicazione delle ricerche motivazionali allo studio del mercato, includeva nel titolo gli "ingredienti" della svolta che si traduce nell’istituzione di Demoskopea: lo spostamento del baricentro strategico dall’indagine d’opinione alla ricerca di mercato, e la conseguente scelta di privilegiare una committenza privata a quella – prevalentemente pubblica – su cui allora lavorava Doxa. Si tratta di un punto fondamentale, perchè consente allo storico di osservare i successivi sviluppi dell’impresa Demoskopea riferendosi costantemente ai fattori intellettuali e di mercato che di questa società hanno rappresentato le premesse.
Fabris ed Erminero lasciano la Doxa proprio perché insoddisfatti del profilo complessivo di quella grande società. I due, insieme a Bartolo Mardesich (che però interrompe il rapporto con Demoskopea nel 1967), si concentrano sull’idea di un istituto che metta al servizio del mercato un’attività ben bilanciata di ricerche qualitative e quantitative, capace di avvalersi delle nuove metodologie che proprio nei primi anni Sessanta si affacciano sulla scena italiana. Si tratta delle ricerche motivazionali promosse da Ernest Dichter, attorno alle quali ragionano alcune tra le personalità più coinvolte nel rinnovamento del settore; Fabris, Francesco Alberoni, Gabriele Calvi (il fondatore, nel 1972, di Eurisko), Giulia Camusso, Carlo Carli, Marino Livolsi sono alcuni tra gli studiosi che – stabilendo nessi molteplici tra ambienti accademici e imprese – si cimentano in questo tentativo, come testimoniato da numerosi saggi apparsi sulla rivista Ricerche motivazionali (fondata nel 1964 e diretta dallo stesso Fabris; si pubblicano anche diversi articoli di Carlo Erminero, sovente relativi al mercato pubblicitario) oltre che su Ricerche Demoscopiche, "bimestrale di indagini sociologiche e di opinione pubblica della Demoskopea" (il cui primo numero è pubblicato nel 1969).
Fabris, Francesco Alberoni, Gabriele Calvi (il fondatore, nel 1972, di Eurisko), Giulia Camusso, Carlo Carli, Marino Livolsi sono alcuni tra gli studiosi che – stabilendo nessi molteplici tra ambienti accademici e imprese – si cimentano in questo tentativo, come testimoniato da numerosi saggi apparsi sulla rivista Ricerche motivazionali (fondata nel 1964 e diretta dallo stesso Fabris; si pubblicano anche diversi articoli di Carlo Erminero, sovente relativi al mercato pubblicitario) oltre che su Ricerche Demoscopiche, "bimestrale di indagini sociologiche e di opinione pubblica della Demoskopea" (il cui primo numero è pubblicato nel 1969).
 La società Misura, fondata da Piero Bassetti a Milano nel 1959 - costruita sull’applicazione delle ricerche motivazionali e su una chiarissima impostazione di tipo qualitativo - raccoglie alcune tra queste personalità, in parte confluite in Demoskopea nel 1965 (è il caso di Giulia Camusso, psicologa e – appunto – motivazionalista).
La società Misura, fondata da Piero Bassetti a Milano nel 1959 - costruita sull’applicazione delle ricerche motivazionali e su una chiarissima impostazione di tipo qualitativo - raccoglie alcune tra queste personalità, in parte confluite in Demoskopea nel 1965 (è il caso di Giulia Camusso, psicologa e – appunto – motivazionalista).
Gli anni sessanta
|
 |
Il mercato italiano degli anni Sessanta è dunque presidiato dalle tre realtà citate – Doxa, Misura, Demoskopea, e il settore non si caratterizza per una concorrenza agguerrita. Si tratta però di conquistare la committenza privata, tradizionalmente aliena dagli investimenti nella ricerca . Il primo contratto rilevante per Demoskopea è una indagine di readership sulla stampa quotidiana (l’attuale Audipress), che consente alla società di “istituzionalizzarsi” e acquistare nuove committenze, mentre va definendosi la struttura interna, con una divisione funzionale del lavoro il cui perno è rappresentato – come già detto - dalle figure di Carlo Erminero e Giampaolo Fabris (attorno ai quali, negli anni, si formano professionalemente alcuni dei nostri testimoni, come Marilù Faustinelli Bonetti – che però rimane poco in Demoskopea – Alessandro Cortellazzo, Anna Zamboni, Giorgio Villa).
. Il primo contratto rilevante per Demoskopea è una indagine di readership sulla stampa quotidiana (l’attuale Audipress), che consente alla società di “istituzionalizzarsi” e acquistare nuove committenze, mentre va definendosi la struttura interna, con una divisione funzionale del lavoro il cui perno è rappresentato – come già detto - dalle figure di Carlo Erminero e Giampaolo Fabris (attorno ai quali, negli anni, si formano professionalemente alcuni dei nostri testimoni, come Marilù Faustinelli Bonetti – che però rimane poco in Demoskopea – Alessandro Cortellazzo, Anna Zamboni, Giorgio Villa).
I profili "complementari" dei due ricercatori consentono a Erminero di sviluppare prevalentemente le ricerche quantitative, inclusi una serie di servizi ad andamento periodico o continuativo - quali il Panel famiglie, su cui tornerò, il Panel librerie per editori come Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli, e ricerche sul mercato pubblicitario e sul mondo del credito -, cui associa la cura di buona parte degli aspetti amministrativi, mentre Fabris si concentra su importanti ricerche mirate, perlopiù qualitative.
Erminero, riflettendo sulle differenze tra Demoskopea e Doxa in quegli anni, insiste sul fatto che Doxa, occupandosi prevalentemente dell’analisi dell’opinione pubblica (attraverso la ricerca statistica), non aveva sviluppato una cultura di servizi alle imprese, cioè una cultura rivolta alla ricerca di marketing . L’analisi dei comportamenti svolta da Doxa, secondo Erminero, trascurava l’approfondimento delle motivazioni: ciò implicava una difficoltà di comprensione dei comportamenti che venivano descritti (cosa che invece - nell’ottica delle imprese industriali che avrebbero dovuto richiedere le ricerche - sarebbe stata utile, determinante). Anche da questo, spiega Erminero, dipende l’uscita sua e di Fabris da Doxa.
. L’analisi dei comportamenti svolta da Doxa, secondo Erminero, trascurava l’approfondimento delle motivazioni: ciò implicava una difficoltà di comprensione dei comportamenti che venivano descritti (cosa che invece - nell’ottica delle imprese industriali che avrebbero dovuto richiedere le ricerche - sarebbe stata utile, determinante). Anche da questo, spiega Erminero, dipende l’uscita sua e di Fabris da Doxa.
Sono gli anni in cui Giampaolo Fabris, intrecciando all’attività dell’impresa una costante produzione editoriale, sviluppa uno dei suoi cardini teorici, diventato patrimonio di Demoskopea: la necessità di studiare l’individuo come presupposto per comprenderne le scelte di consumo. Il consumatore dunque non esiste; esiste e va studiata la persona all’interno della società (impostazioni che si arricchiscono nella frequentazione da parte di Fabris di George Katona, uno dei fondatori della psicologia economica).
Demoskopea conquista gradualmente committenze: alcune di esse sono società petrolifere: l’impresa segue il lancio di Total in Italia e collabora con Esso e Shell. Importante anche il settore alimentare: la Buitoni Perugina è il più grande cliente di Demoskopea in questo ramo, e negli anni seguiranno Ferrero, Pavesi, Lavazza, Stock, Knorr ed altre; e poi, tra i primi, CGE, Candy, Unilever, Mondadori.
L’impresa inizia a caratterizzarsi realizzando ricerche integrate (qualitative e quantitative) molto vaste, raccogliendo intorno al nucleo dei fondatori circa settanta collaboratori - provenienti da altre imprese o giovani laureati con propensione alle ricerche motivazionali (alcuni di essi hanno poi dato vita autonomamente a società demoscopiche) - e investendo in politiche di espansione che, nonostante l’aumento sensibile dei costi, sono incentivate dal rilievo acquisito sul mercato dal nome della società.
Tra le attività di traino per lo sviluppo di Demoskopea, la ricerca OTP - un’indagine periodica, di scala nazionale, sulla lettura dei giornali, finanziata prevalentemente da editori e pubblicitari - riveste un ruolo particolare e ambivalente: da un lato perché consente alla Demoskopea della seconda metà degli anni Sessanta di applicare intensivamente gli strumenti metodologici messi a punto in quella fase; dall’altro perché la sua improvvisa sospensione da parte degli editori, nel 1972, costringe la società a licenziare circa un terzo dei dipendenti, proprio nel momento in cui gli ingenti investimenti effettuati iniziano a tradursi in utili d’esercizio.
Gli anni settanta
|
 |
La coincidenza con la generale crisi economica di inizio anni Settanta, più volte richiamata nelle relazioni allegate ai bilanci, non frena però lo sviluppo di Demoskopea, che nel frattempo ha trasferito e notevolmente ampliato la sede, da Via Podgora ai nuovi uffici di Viale Majno. Le vicende del mercato editoriale si intrecciano a quelle della società, inaugurando relazioni di lungo periodo che sono altrettante "finestre" sulle trasformazioni della società italiana: Demoskopea collabora infatti, a più riprese, con il periodico L’Espresso, pubblicando sondaggi - cui il giornale solitamente dedica la copertina – in occasione delle elezioni politiche e dell’elezione del Presidente della Repubblica (1971), e sul tema del divorzio, (referendum sulla legge Fortuna-Baslini, 1974).


Demoskopea esegue inoltre le ricerche per la scelta del nome, il posizionamento e il lancio del quotidiano La Repubblica; lavora per Il Giorno (indagando tra l’altro l’appetibilità – per i lettori – dell’introduzione di immagini a colori sui quotidiani), cura ricerche di readership per La Stampa (coinvolgendo, come collaboratori esterni, Stefano Draghi – professore di metodi quantitativi per la ricerca sociale - e Angelo Pagani) e successivamente ne redige la classifica Tuttolibri .
e successivamente ne redige la classifica Tuttolibri .
 Nella seconda metà degli anni Settanta i sondaggi della società vengono sovente commissionati e pubblicati da Panorama. Oltre a ricerche pre-elettorali su campioni particolarmente vasti (in occasione delle elezioni politiche del 1977 e del 1979), il settimanale ospita dettagliati resoconti di sondaggi Demoskopea sulla trasformazione della famiglia tradizionale, sull’aborto (in collaborazione con il Cisa di Emma Bonino) e sulla nuova fisionomia della popolazione universitaria.
Nella seconda metà degli anni Settanta i sondaggi della società vengono sovente commissionati e pubblicati da Panorama. Oltre a ricerche pre-elettorali su campioni particolarmente vasti (in occasione delle elezioni politiche del 1977 e del 1979), il settimanale ospita dettagliati resoconti di sondaggi Demoskopea sulla trasformazione della famiglia tradizionale, sull’aborto (in collaborazione con il Cisa di Emma Bonino) e sulla nuova fisionomia della popolazione universitaria.
Sebbene, come accennato sopra, Demoskopea tenda per vocazione a privilegiare il rapporto con il mercato, offrendo strumenti per una committenza composta da imprese, le collaborazioni citate – unitamente alle apparizioni su RAI 2 per le proiezioni elettorali del 1979 - costituiscono il trait d’union con la sfera della politica, che proprio in quel periodo comincia a considerare con sguardo nuovo (anche nella sinistra, tradizionalmente sospettosa e scettica nei confronti delle ricerche di opinione) lo strumento del sondaggio, tanto da determinare negli anni successivi il fenomeno che altri hanno chiamato sondomania e che non può essere oggetto di questo breve intervento, se non per rimarcare proprio il carattere di transizione degli anni Settanta.
Quanto qui preme sottolineare è che il caso di Demoskopea esemplifica la permeabilità degli istituti di ricerca alle correnti culturali ed economiche che attraversano la società, e con essa il mondo delle imprese; queste ultime, interessate tra le due guerre da un lento processo di ricezione delle tecniche di razionalizzazione produttiva, hanno poi faticato moltissimo a dotarsi degli strumenti atti a razionalizzare la distribuzione; si pensi – e qui possono collocarsi le speranze e i tentativi, da parte di Demoskopea, di indirizzare la propria committenza – alla ritardata adozione nel mercato italiano delle ricerche sulla pianificazione e sull’efficacia della pubblicità. In questo campo Demoskopea interviene, sempre in relazione con il mercato editoriale, con un controllo periodico sulla pubblicità a stampa – IPS – costituendo una banca dati composta da migliaia di annunci pubblicitari e impegnando il gruppo di ricercatori nella definizione di profili molto accurati dei lettori da intervistare.
Anche le indagini Omnibus, largamente utilizzate da Demoskopea a partire dal 1975, suppliscono alla scarsa propensione all’investimento da parte delle imprese.
In uno stesso questionario, somministrato ad un nutrito numero di individui e famiglie attraverso interviste personali, vengono infatti inserite domande commissionate da diversi clienti, e i risultati dell’indagine permettono di verificare

preferenze, comportamenti d’acquisto, ricordo della pubblicità.
Nella direzione dello studio dei comportamenti e della loro evoluzione nel tempo, con possibilità di indagine su vasta scala, viene costituito negli anni Settanta il Panel Famiglie, mentre già da tempo si effettuano ricerche motivazionali molto accurate; citiamo il caso dell’indagine svolta nel 1969 per la
Zanussi, il cui obiettivo è verificare l’atteggiamento verso la possibile produzione e commercializzazione dei primi videoregistratori. In questo caso gli strumenti di rilevazione comprendono 60 colloqui

eseguiti in diverse città d’Italia da psicologi collaboratori esterni di Demoskopea, seguiti da riunioni di gruppo. I risultati dell’indagine illustrano l’atteggiamento del campione nei confronti della Tv e degli altri mass-media, e comprendono l’intera fase di vita del prodotto da realizzare (aspettative dei possibili consumatori in relazione al funzionamento dello strumento, ai canali di distribuzione, ai prezzi, alla significatività dei nomi proposti).
Come detto, le ricerche motivazionali sull’evoluzione del mercato presuppongono per Demoskopea lo studio degli individui, e l’ampiezza delle indagini effettuate restituisce spesso al lettore - e alle imprese – uno spaccato della società in trasformazione. Durante il convegno nazionale “Il mercato e la donna” (Genova, 21-23 novembre 1968),

Demoskopea presenta una ricerca,
La donna consumatrice, che indaga – parallelamente al progressivo ampliarsi del ruolo della donna nelle decisioni di acquisto – il mutamento della sua posizione nella società, in relazione alla famiglia, al lavoro, al tempo libero; e nella relazione introduttiva di Fabris (la ricerca è stata coordinata da Giulia Camusso) si attacca
"(…) il nuovo mito (ma vecchio modello) di donna angelo del focolare (…)".
Gli esempi riportati, che naturalmente rappresentano solo un frammento delle attività di Demoskopea, ci consentono di comprendere l’importanza attribuita dalla società alla messa a punto, sulla base di esperienze francesi alle quali Demoskopea si collega, del metodo
3SC, un monitoraggio iniziato nel 1977, proposto ad un ampio gruppo di grandi imprese italiane – prima tra queste la
FIAT – e considerato da Giampaolo Fabris un nuovo modo di studiare il mercato: si tratta
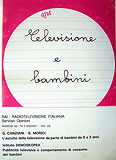
di analizzare i trends sociali e fornire alleimprese gli scenari di cambiamento, calandoli poi nei singoli comparti produttivi (fashion, automotive, ecc) con la possibilità per i committenti di inserire domande specifiche.
La collaborazione di Demoskopea con la televisione pubblica, cominciata alla fine degli anni Sessanta, segue diversi filoni: il Servizio Opinioni RAI commissiona alla società indagini approfondite, quali ad esempio
Televisione e bambini. L’ascolto della televisione da parte dei bambini da 0 a 3 anni (1975).



Lo stesso servizio re0alizza, ad uso interno, sintesi dei sondaggi Demoskopea pubblicati sui periodici (nel 1970 furono trascritti i risultati su un sondaggio relativo al comportamento dei giovani, apparso su
L’Espresso).
Negli anni Novanta la collaborazione con la RAI proseguirà sia attraverso apparizioni televisive dei membri di Demoskopea, sia tramite sondaggi commissionati dal servizio pubblico (
Gli italiani e la televisione, 1996;
Tivù delle mie brame. Quello che gli italiani guardano e quello che vorrebbero guardare, 1996;
La riorganizzazione dei palinsesti di Radio RAI, ipotesi “grafiche”, 1999).

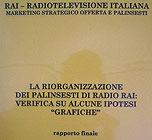

Da citarsi inoltre, per la rilevanza dei soggetti coinvolti, gli impegni di Demoskopea su committenza del settore bancario: le ricerche svolte per l’
ABI in occasione del lancio in Italia del servizio bancomat e quelle di marketing per il
Banco di Napoli, curate da Carlo Erminero.

Dell’attenzione nell’impresa per le correnti ideali attive nella società – legame multiforme di cui abbiamo ampiamente dato conto - si trova ulteriore traccia in un lavoro di metà anni Ottanta:
Una Repubblica migliore per gli italiani. Sondaggio Demoskopea sulle proposte di riforma della Costituzione del Gruppo di Milano (coordinato da Gianfranco Miglio),
maggio 1985 .
.
Si è accennato ai collegamenti internazionali. Demoskopea collabora dal 1970 alla redazione del codice ESOMAR/CCIA (codice professionale dei ricercatori europei); partecipa allo sviluppo di un network internazionale – il RISC – di società che condividono impostazioni e metodo di lavoro; nel 1980 entra nella rete IRIS, composta da istituti europei tra loro coordinati per lo svolgimento di ricerche internazionali. In seguito stabilisce collegamenti con il gruppo
Sherman (USA) e il gruppo Mori

.
Gli anni ottanta
|
 |
La fine degli anni Settanta è caratterizzata da cicliche incertezze finanziarie e ripetuti aumenti di capitale, con bassi margini di remunerazione dello stesso. Nel 1980, Demoskopea cambia nuovamente sede, trasferendosi negli uffici di via Bixio. Gli anni che seguono porteranno al distacco di Giampaolo Fabris da Demoskopea (la sua decisione di uscire dal consiglio di amministrazione è del 1983) e all’ingresso di nuove figure nella struttura della società, che nel 1986 realizza accordi di licenza con il gruppo AIM-Sherman e ottiene le più importanti ricerche italiane sui mezzi stampa - ISPI e ISEGI - procedendo poi alla trasformazione della struttura operativa (tre nuove divisioni: marketing, editoriale, comunicazione) e istituendo un reparto ad hoc per le ricerche motivazionali. L’anno dopo Demoskopea partecipa alla costituzione di Computel (realizzazioni di inchieste telefoniche; la società sarà incorporata nel 1990) e, in seguito a nuovi aumenti di capitale, si trasforma in società per azioni
e all’ingresso di nuove figure nella struttura della società, che nel 1986 realizza accordi di licenza con il gruppo AIM-Sherman e ottiene le più importanti ricerche italiane sui mezzi stampa - ISPI e ISEGI - procedendo poi alla trasformazione della struttura operativa (tre nuove divisioni: marketing, editoriale, comunicazione) e istituendo un reparto ad hoc per le ricerche motivazionali. L’anno dopo Demoskopea partecipa alla costituzione di Computel (realizzazioni di inchieste telefoniche; la società sarà incorporata nel 1990) e, in seguito a nuovi aumenti di capitale, si trasforma in società per azioni .
.
Conclusioni
|
 |
Come accennato in apertura del presente scritto, si è inteso qui fornire gli spunti per uno studio sulla “seconda generazione” di istituti italiani d’opinione e di ricerche di mercato, apertasi negli anni Sessanta con la costituzione di Demoskopea (della quale si è tentato di delineare ascendenze e distanze dalla capostipite Doxa), cui si aggiunge a partire dal 1972 l’Eurisko di Gabriele Calvi. L’evoluzione di queste imprese negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, se da un lato – proprio grazie alla specifica funzione di “ricettori” delle trasformazioni sociali – consente di cogliere i segni delle grandi evoluzioni culturali e dei nuovi orientamenti al consumo, dall’altro può offrire, se studiata approfonditamente e in ottica comparata, alcune risposte alla domanda di fondo, accennata anche nel corso di questo scritto, sui motivi della tardiva adesione delle imprese italiane alla produzione marketing oriented e all’indagine di mercato.
Infine, il caso di Demoskopea e delle altre imprese di marketing ed opinione pubblica “di seconda generazione” dovrebbe permettere di leggere più nitidamente la fase in cui – tra la fine del boom e le crisi di metà anni Settanta – il restringimento degli spazi di mercato avrebbe dovuto indurre le imprese a un ricorso massiccio agli strumenti – del resto rinnovatisi, come si è detto – forniti loro dalle società demoscopiche. Ciò è avvenuto solo parzialmente, e l’attuale situazione di grande frammentazione del settore di cui parliamo (a dispetto del ciclico dibattito sulla “sondomania”) dovrebbe rappresentare una ulteriore sollecitazione agli studi.
Bibliografia di riferimento

