L’unicità della Olivetti
L’impiego delle fonti orali
Testimonianze dentro Olivetti, dal tema non si esce mai
L’unicità della Olivetti
I titoli servono per portare, senza equivoci, dentro l’argomento e le sue pertinenze. 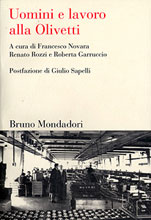 Così è per l’accurata raccolta di testimonianze orali sul senso e sulla pratica del lavorare in Olivetti edita da Bruno Mondadori sotto il titolo Uomini e lavoro alla Olivetti. Non è occorso neppure l’espediente chiarificatore di un sottopancia (didascalia). Di meglio era forse impossibile fare, anche se la con-giunzione di mezzo tra «uomini» e «lavoro» distingue due termini che le pagine del libro e le parole dei testimoni lasciano fluire in continuo tra umanità e lavoro, pregio e unicità dell’Olivetti di Adriano. Lì dove Giulio Sapelli (nella post-fazione) rintraccia «una produzione mitologica … indispensabile allorché si voglia inserire in una cornice culturale la lettura e la meditazione delle storie di vita» (p. 607) raccolte nel volume. Mondi vitali e valori condivisi, svenduti come miti d’oggi, prosegue Sapelli, nella recente dissipazione di un patrimonio di lealtà organizzativa di cui danno memoria Francesco Novara e Renato Rozzi: «Se in altre aziende il lavoratore si confondeva in una massa indifferenziata, in Olivetti egli era una persona con una vita lavorativa ben individuata».
Così è per l’accurata raccolta di testimonianze orali sul senso e sulla pratica del lavorare in Olivetti edita da Bruno Mondadori sotto il titolo Uomini e lavoro alla Olivetti. Non è occorso neppure l’espediente chiarificatore di un sottopancia (didascalia). Di meglio era forse impossibile fare, anche se la con-giunzione di mezzo tra «uomini» e «lavoro» distingue due termini che le pagine del libro e le parole dei testimoni lasciano fluire in continuo tra umanità e lavoro, pregio e unicità dell’Olivetti di Adriano. Lì dove Giulio Sapelli (nella post-fazione) rintraccia «una produzione mitologica … indispensabile allorché si voglia inserire in una cornice culturale la lettura e la meditazione delle storie di vita» (p. 607) raccolte nel volume. Mondi vitali e valori condivisi, svenduti come miti d’oggi, prosegue Sapelli, nella recente dissipazione di un patrimonio di lealtà organizzativa di cui danno memoria Francesco Novara e Renato Rozzi: «Se in altre aziende il lavoratore si confondeva in una massa indifferenziata, in Olivetti egli era una persona con una vita lavorativa ben individuata».
1934: ai coevi stereotipi produttivi stilizzati nei raptus di Charlie Chaplin in «Tempi moderni», la Chevrolet rispondeva tempestivamente producendo il filmato Master hands (http://www.archive.org/details/prelinger).
I primi fotogrammi vedevano la progressiva messa a fuoco di sagome senza volto: dalla massa indistinta di tute vivificate, emergeva man mano la fisionomia degli uomini diretti in fabbrica. Per quaranta minuti segue poi un’accurata prospezione dell’intero processo produttivo, dal primo interruttore alzato all’alba per produrre l’energia che risveglia lo stabilimento, sino alla vettura finita e rifinita che si allontana per il collaudo. Il tutto per dimostrare come la catena di montaggio non fosse altro che sequenza di un processo produttivo in grado di salvaguardare, al proprio fianco, professionalità, competenze, autorità del lavoro: le permanenze artigiane nel fordismo rampante oltre oceano. Invero è poi la brutalità delle immagini sulla catena, tra uomini e automatismi, a restare nei nostri occhi: la rivincita di Chaplin. Ben oltre la volontà di chi il film ha prodotto, uomini e lavoro disgiunti per senso, congiunti per servitù. Contro l’indistinto, l’emersione dei volti pone allo storico le stesse domande che

(ascoltate o meno) poneva al datore di lavoro.
Nel dare voce a venticinque testimoni Roberta Garruccio mette a fuoco «la politica del personale che ha caratterizzato la grande stagione (e la grande eccezione) dell’Olivetti … una politica del personale che puntava alla gestione e allo sviluppo delle persone più che a preoccuparsi delle tecnicalità e degli specialismi della funzione oggi chiamata “risorse umane”» (p. 11). Nell’Italia del dopoguerra la sala dove scorreva il filmato dell’Olivetti non aveva altro in programmazione. Gli attori che si raccontano in questo libro ci spiegano bene l’anima di quel genere unico. L’invettiva «day after» di Francesco Novara (una paginetta a inizio volume) è una duplice chiamata di responsabilità: per chi ha scelto di sacrificare un patrimonio imprenditoriale ponendo di fatto fine alla storia dell’azienda e per lo storico consapevole delle responsabilità civili insite nel ricostruire la memoria. Ma traccia anche una possibile via per il necessario riscatto tra uomo e lavoro: «A un mondo del lavoro umiliato in una società lacerata e disorientata, succube delle vicende aleatorie di un’economia finanziarizzata, si rivolge il coro di queste testimonianze. Esse ricordano il valore permanente delle ragioni di quel successo d’impresa: la responsabilità e capacità di costante innovazione e anticipazione, realistica e audace, razionale e immaginativa, votata all’eccellenza dei prodotti, alla qualità della vita lavorativa, all’elevazione della vita sociale». Contro la dispersione perpetrata a fine Novecento, l’affilata penna di Sapelli diventa bisturi, senza timore di incidere i nomi nella transizione dalla lealtà organizzativa degli uomini alle indecenti sopravvivenze degli ossequi senza fedeltà quando le imprese rinunciano a intraprendere. Il messaggio del libro va oltre. Chiama in causa l’incontro possibile della vita di lavoro (e di non lavoro) con gli stili della nostra convivenza civile. Ci mette in gioco tutti dal momento che per dare senso ai fatti degli uomini e delle imprese, del lavorare e dell’associarsi, le azioni non bastano senza il richiamo «agli ideali, agli obiettivi ultimi, alle concezioni essenziali, [dato che] ogni onesto uomo deve cercare soltanto di portare avanti le cose in cui crede senza timori e senza baratti» (M. Romani).
L’impiego delle fonti orali
|
 |
In questo annullarsi del tempo storico le 639 pagine del libro potevano rischiare il proprio rigore. Ben venga una post-fazione che si fa carico del tragitto tra storia e antropologia e richiama legami indotti dalla stessa natura della fonte quando è voce narrante in prima persona. Ma questo tragitto richiedeva fondamenta solide nel lavoro storico, operazione ardua nell’impiego delle fonti orali nonostante l’apprezzamento di molti ambienti scientifici (http://alpha.dickinson.edu/oha/). Basi che non potevano venire dai testimoni. Solo l’estenuante fatica dell’intervistatore poteva liberare dal peso delle retroazioni, delle sfumature a perdere della memoria, della nostra incapacità a raccontare il quotidiano quando il giorno manca delle eccezionalità che segnano la vita e il ricordo.
L’intervistatrice, in questo caso, ha potuto certamente contare sul vantaggio dell’eccezionalità quotidiana del lavoro in Olivetti non meno che sull’autorità di una memoria del lavoro non dispersa. Roberta Garruccio ha girato il Canavese e parte del Piemonte, con qualche puntata altrove, oltre che presso il Centro cultura d’impresa, per raccogliere le venticinque voci. Ha dato rigore al materiale storico prodotto dai dialoghi; ha fatto tesoro delle competenze messe a punto nelle altre sue ricerche. Nelle pagine introduttive ha indossato le vesti dell’aedo cieco, ha dichiarato l’ipotesi di lavoro e dipanato la tesi; consapevole, con rigore e senza facili enfasi, della natura e dei limiti del progetto e della sua realizzazione. Compreso l’indispensabile adattamento del parlato allo scritto, sacrificio imposto dal supporto cartaceo che scarnifica voci e gesti per ricostruire in altro modo la capacità comunicativa della registrazione originaria così da rendere le pagine a stampa «intelleggibili per qualsiasi lettore» (p. 63). Il filtro editoriale non ha per ora alternative nel dialogo sperimentale tra carte, voci e immagini; tra archivi tradizionali e mediateche (http://www.ips.it/cinethes/mov_op. html). Non è ancora il tempo di giungere alla meta delle voci ascoltate, dei volti non solo immaginati, incapaci come siamo di fruire rigorosamente di tutti i supporti della conoscenza.
Il corredo di note posto con accuratezza ai singoli testi è indispensabile, così come la cronologia finale, tanto per il lettore puntiglioso quanto come possibile ponte per l’incontro, rinviato ma prima o poi necessario, con le documentazioni «tradizionali» in ragione di una ricostruzione che non distingua le fonti per tipologia. Nella sua originalità, il libro propone anche alcune dense pagine che alla cecità esterna dell’aedo mettono gli occhi di chi era dentro la storia e non è stato estraneo alla promozione dell’intera opera: Francesco Novara e Renato Rozzi, psicologi che hanno operato a lungo nel Centro di psicologia Olivetti. Filtri indispensabili per riportare le memorie individuali a quella memoria collettiva di cui si sentono parte. Con il loro aiuto diventa più facile entrare nel merito delle tematiche trattate: le relazioni aziendali e quelle sindacali, la produzione, la ricerca & sviluppo, i servizi commerciali, l’alta direzione, i servizi culturali e sociali.
Testimonianze dentro Olivetti, dal tema non si esce mai
|
 |
Come dice il Principe felice di Wilde «mi racconti cose meravigliose ma più meravigliosa di tutto è la sofferenza di uomini e donne». A parte il genere (una sola la donna intervistata), è cosa di meraviglia la sofferenza di quegli uomini quando vedono svuotarsi il senso del proprio lavoro e inaridire la disciplina industriale, ridotti a interpreti minori delle ultime trasformazioni dell’impresa in cui si erano un tempo sentiti risorsa, umana risorsa.
Il filo conduttore del libro scorre tutto dentro l’Olivetti, in controluce leggiamo la filigrana delle trasformazioni organizzative che hanno caratterizzato molte imprese industriali sullo scorcio del Novecento. Le testimonianze, a maggioranza, iniziano dalla domanda «Vorrei che mi raccontasse la sua storia in Olivetti»; poche le varianti ma sempre collocate dall’ingresso in azienda («Come è arrivato all'Olivetti?») in poi. Solo alcuni testimoni danno rapidamente conto di un prima, fatto di studio e di eventuali altre brevi esperienze; qualche maggior respiro ha l’avvio di un ex-amministratore delegato (Ottorino Beltrami) che pur doveva spiegare un handicap fisico subìto in guerra. In un solo caso (stando al testo edito) Garruccio avvia il colloquio con un respiro più ampio, chiede della famiglia, degli studi fatti, della scelta di entrare in Olivetti. Poi chiude la domanda rivelando l’arcano del libro: «Non si preoccupi di uscire dal tema, perché dal tema non si esce mai» (p. 307). Chiaro e semplice. Come a racchiudere tutto. Che dire degli altri arcana celati nel gioco di specchi tra un dentro disciplinato dall’organizzazione e un fuori, riflesso sfuocato dell’azienda nel risalto di ciascun testimone con le sue scelte di vita, la sua cultura del lavoro, la ricerca di un senso pregresso e virtuale prima di condensarlo in azienda, finalmente narrazione vissuta di un sé già in costruzione o costruito? Queste storie dentro l’Olivetti traguardano tutta la vita dei testimoni. Quanto era in loro di Olivetti senza Olivetti, quanto era segnato nelle quotidianità delle famiglie e delle appartenenze sociali, quanto era inciso nelle trame occulte della loro generazione e dei processi culturali in cui erano immersi, quanto nel Canavese, prospero anche per chi aveva altre radici? Condotte con maggior decisione fuori dalla fabbrica, queste storie di vita avrebbero spiegato meglio la meraviglia delle passioni e delle sofferenze dentro la fabbrica? In termini di metodo, la cesoia di quella prima domanda insistente («la sua storia in Olivetti») invece di potare in vista dei migliori frutti, ha indebolito la pianta?
Si direbbe una pretesa ingestibile se non scaturisse da quanto i testimoni hanno travasato nelle loro parole. Naturalmente ogni ipotesi di lavoro deve darsi dei limiti, che vanno rispettati nel loro assoluto decoro scientifico e riducono le recensioni al mero esercizio calligrafico: le buone ipotesi di ricerca e i buoni lavori lasciano comunque il segno. Aprono, lo sappiamo bene, su confini più ampi, non implodono nei baratri dell’intelligenza. Ogni tematica trattata nel volume offre spunti, fa sorgere domande, stimola riflessioni ulteriori. Occorre solo leggere queste pagine.
E’ una buona lettura, da adottare anche in qualche corso universitario pertinente, per tentare di aprire un dialogo con la disattenzione prevalente in chi, atteso a breve sul mercato del lavoro, dovrà negoziare tra identità individuale e identità collettiva rischiando di non avere senso della storia, di quel che è stato, nella norma o in via eccezionale. Se un libro non educa a che serve? Verificheremo queste pagine fra un anno, dopo qualche decina di esami. Nel timore di aver inseguito «solo» un mito.
