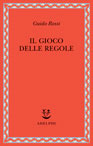 Guido Rossi, esperto internazionale di diritto societario e grande avvocato d’affari milanese, con questo agile saggio su “Il gioco delle regole” riprende il ragionamento avviato tre anni fa ne “Il conflitto epidemico” (Adelphi, 2003), allargandone gli scenari di riferimento.
Guido Rossi, esperto internazionale di diritto societario e grande avvocato d’affari milanese, con questo agile saggio su “Il gioco delle regole” riprende il ragionamento avviato tre anni fa ne “Il conflitto epidemico” (Adelphi, 2003), allargandone gli scenari di riferimento.
Allora il tema erano gli squilibri nel capitalismo finanziario (conflitti di interesse), in via di transizione dallo stato “endemico” a quello “epidemico”, quali agenti di sopraffazione che tendono a istituzionalizzare le disparità (per cui, inquinando il corretto funzionamento degli scambi, insidiano le ragioni stesse dell’economia di mercato). Ora l’analisi prende in esame la distruzione di ogni forma di controllo che mette a repentaglio persino il principio di ordinamento giuridico.
Ancora una volta la matrice del cambiamento viene individuata nelle trasformazioni dell’economia capitalistica, in questa fase di crescente finanziarizzazione che recalcitra ad ogni forma di controllo. Dunque la tendenza a sostituire le norme generali con accordi pattizi tra privati contraenti (e a tutto vantaggio di quelli più forti), quale via di fuga dalla giurisdizione statuale.
Una privatizzazione delle regole che Rossi definisce - con un termine a rischio di ingenerare non poca confusione - “contrattualismo”. Del resto, fenomeno investigato già dieci anni fa da Saskia Sassen, docente di pianificazione urbana dell’Università di Chicago.
Già docente della Columbia University di New York, Saskia Sassen è nota in tutto il mondo per i suoi studi sulla globalizzazione. È autrice - tra l’altro - di
Le città globali (Torino UTET 1997),
Le città nell’economia globale (Bologna Il Mulino

1997) e
Migranti, coloni e rifugiati (Milano Feltrinelli 1999)
come nascita alluvionale di un “diritto internazionale privato” attraverso gli arbitrati dei grandi studi legali anglo-americani e le valutazioni operate dalle agenzie oligopolistiche nel mercato del
rating; in particolare
Moody’s e
Standard and Poor’s (
Fuori controllo, Il Saggiatore Milano, 1998).
Osserva Rossi: “nonostante le intemperanze cui spesso si abbandonano i fautori più estremi del libero mercato, l’unico strumento ad oggi disponibile per la tutela dell’interesse generale rimangono le norme. È di questo paradosso che il sistema si ritrova prigioniero. In altre parole, la riduzione dell’intero corpo sociale a una folla di contraenti, e dello Stato a grande mediatore fra interessi contrattuali diversi, comporta un sostanziale svuotamento della legge” (pag. 26).
Insomma, le recenti tendenze alla deregolamentazione dei mercati in tutti i paesi a capitalismo avanzato rappresentano l’ulteriore prova contro l’esistenza di un ordine rigorosamente legislativo del mercato. Un
trend in accelerazione.
Perché - dunque -
l’impresa irresponsabile? Su questo punto al giurista Rossi può venire a supporto il sociologo
Luciano Gallinoche, in un volume dell’anno passato, ricostruiva le ragioni profonde delle tendenze in atto. Ossia la nascita del “capitalismo manageriale azionario”; che vede le proprietà - dopo la lunga fase di assenteismo tra il dopoguerra e la seconda metà degli anni 70 - ritornare a indirizzare i criteri gestionali delle aziende, in alleanza con i manager. Alleanza foraggiata con la spartizione dei robusti dividendi borsistici assicurati dalle operazioni speculative (
L’impresa irresponsabile, Einaudi 2005, pag. 35). Un
trend abbastanza catastrofico, non solo per gli effetti sociali ma anche per i risultati di medio periodo di aziende imprigionate dalla logica della monetizzazione dei risultati a breve e nel dilagare dell’irresponsabilità gestionale. Ne è lampante conferma la sequela di scandali economici di questi ultimi anni: dall’Enron alla Parmalat. Cui non ha portato nessun giovamento la proliferazione di strumenti per l’autogoverno societario come i cosiddetti
Codici Etici (“galatei aziendali”, li definisce ironicamente Rossi).
D’altro canto la
deregulation del diritto a livello globale finisce per sconnettere non solo le funzioni regolative dello Stato, arriva a investire gli embrionali tentativi di costituire un sistema istituzionale mondiale. Infatti, la crisi in cui sono precipitate le Nazioni Unite, a seguito dell’oscuramento durante la crisi irachena, vede emergere come unico organismo internazionale ancora
sul campo il
WTO (World Trade Organization), non certo il miglior bastione per difendere i diritti umani, contrastare il terrorismo internazionale e governare giuridicamente le accelerazioni imposte dalle nuove tecnologie (dalla ricerca in biologia al diritto di proprietà intellettuale).
Quali vie d’uscita? Qui il discorso di Rossi tende necessariamente a farsi più vago: ricomporre una capacità sanzionatoria delle norme attualizzando l’utopia kantiana dello
ius cosmopoliticum e tornare a diffondere una cultura che ostracizzi il comportamento scorretto. La condanna sociale rappresentata dal discredito (“sanzione di vergogna”). Come avveniva a Genova già alla fine del medio evo, con il creditore insolvente esposto nudo su una lastra di ardesia (
chiappa) al ludibrio dei mercanti che transitavano nella centralissima piazza Banchi.
PFP.
