|
|
|
 |
recensioni |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
M. Granata, Cultura del mercato. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
concorrenza (1961-1965),
prefazione di Giuliano Amato, postfazione di Sabino Cassese,
Rubbettino-Centro per la cultura d’impresa, Soveria Mannelli, 2008, pp. 294, € 22,00
recensione di Piero Bassetti
|
 |
Ingrandisci
il testo |
 |
 |
|
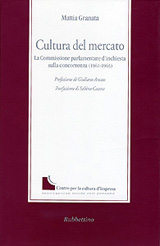 Libro interessante su un episodio politico sicuramente meno interessante. L’inchiesta poteva, infatti, essere svolta «sul serio» o «per burla» – fu fatto notare da Ernesto Rossi a Roberto Tremelloni, presidente della Commissione “antimonopolio”, che, per essere un socialista, secondo lui si rivelava avere «troppi riguardi per tutti i potenti della terra»: realizzare quell’inchiesta «sul serio» significava produrre sì studi, ma anche sviluppare una vera e propria attività inquirente. Libro interessante su un episodio politico sicuramente meno interessante. L’inchiesta poteva, infatti, essere svolta «sul serio» o «per burla» – fu fatto notare da Ernesto Rossi a Roberto Tremelloni, presidente della Commissione “antimonopolio”, che, per essere un socialista, secondo lui si rivelava avere «troppi riguardi per tutti i potenti della terra»: realizzare quell’inchiesta «sul serio» significava produrre sì studi, ma anche sviluppare una vera e propria attività inquirente.
Con un giudizio ammantato di realismo, ma un po’ troppo consenziente rispetto alle dinamiche degli equilibri politici, l’autore definisce «velleitaria» la critica di Rossi, perché uno scontro sul problema dei monopoli avrebbe provocato la paralisi della commissione. Anche se ciò era molto probabile, occorre precisare che velleitario dovrebbe essere solo ciò che, pur tentato, non ha raggiunto il fine perseguito. Il giudizio, altrimenti, non contribuisce a suscitare quelle energie ideali che occorrerebbero per mutare uno stato di cose di cui, implicitamente, viene giustificata l’esistenza per il solo fatto di esistere. Un mutamento del quale, a quel tempo, c’era, invece, molto bisogno.
A prescindere dalla proposta di Rossi, appare apodittico ritenere una simile condotta l’unica con possibilità di risultati, come traspare a proposito della condotta di Tremelloni. Un simile giudizio per essere fondato avrebbe dovuto considerare una pluralità di tentativi contestuali, dai quali ne fosse emerso uno più efficace degli altri. Ottenne, invece, buoni risultati l’azione condotta dal primo presidente della Commissione, anche laddove la valutazione dell’autore sembra spingersi un poco oltre quella lecita allo storiografo, manifestandosi, per passione o eccessivo coinvolgimento, come un giudizio politico discutibile. A voler essere sempre e troppo “realisti”, si finisce spesso per non contribuire – tanto con la riflessione storiografica quanto con la prassi politica – alla creazione di quelle condizioni che consentono la realizzazione dell’improbabile e, pertanto, l’innovazione nella società o nella politica.
Con ragione nel libro, al fine di valutare meglio l’attività svolta dalla Commissione, si suggerisce di scindere il valore degli studi dalle risposte politiche espresse. Tenuto per fermo che politicamente fu un fallimento, le analisi condotte dalla Commissione riuscirono a fornire risultati di qualità anche grazie ai poteri speciali di cui essa era dotata e che le permisero, come ha osservato Giuliano Amato, di «conoscere i fatturati delle principali aziende italiane, le loro partecipazioni incrociate, le quote di mercato di operatori in posizione dominante, le modalità operative della Federconsorzi e dell’Ente risi, sino alle basi documentali delle decisioni sui prezzi del Cip». Con il proprio lavoro, la commissione rendeva ufficiali, attraverso il confronto di differenti e autorevoli punti di vista, dopo le rare denunce espresse negli anni in sede pubblicistica, alcune distorsioni e alterazioni nel mercato italiano.
In seguito alla presidenza di Tremelloni – che una certa mediazione tra conservatori e progressisti riuscì pure a realizzare – l’azione condotta sotto Mario Dosi e poi Flavio Orlandi si manifestò lungo una via pressoché opposta a quella che generò il centrosinistra. Questo fatto può suscitare alcune interessanti riflessioni sui rapporti in Italia tra la rappresentanza politica e quella economica durante i primi anni sessanta. Esse non dovrebbero prescindere dal considerare contestualmente la paradossale azione monopolista di intervento di uno Stato che, almeno formalmente, era interessato a difendere la concorrenza dai monopoli. Esse non dovrebbero dimenticare neppure di attribuire il giusto valore anche a un paradosso contenuto in quello precedente: occorreva difendere il mercato da monopoli che non si sapeva bene cosa fossero o, meglio, che assumevano proteiformi significati a seconda della preparazione o dell’orientamento politico dello studioso interpellato. Qualora ce ne fosse stato bisogno, e ammesso che sia servito a qualcosa, dai lavori della Commissione emergeva unanimemente chiaro, tuttavia, che nel mercato non si manifestava un’azione meramente tecnica dell’impresa.
L’analisi di una realtà economica determinata da commistioni politiche fu condotta da un’autorità non indipendente, prodotta da equilibri politici che contribuivano a suggerire una rappresentazione particolare di quella stessa realtà. Essa era costituita da industriali in crisi di identità: circondati da monopoli pubblici, desideravano idealmente una legge “antitrust”, che, nelle circostanze date, più che garantire avrebbe limitato ancor più quella libera concorrenza tanto agognata.
Il libro, indubbiamente, aiuta a capirla.
|
 |
|
| |
|
 |
 |
altre recensioni |
|
|
|
|
 |
