|
|
|
 |
recensioni |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
F. Bulegato, I musei d’impresa. Dalle arti industriali al design,
Roma, Carocci editore, 2008, pp. 208, € 18,60
recensione di Chiara Nenci
|
 |
Ingrandisci
il testo |
 |
 |
|
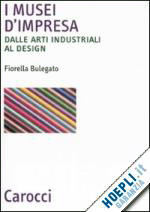 Titolo e sottotitolo del libro di Fiorella Bulegato, oltre a richiamare lo studio pionieristico di Ferdinando Bologna Dalle arti minori all’industrial design. Storia di un’idea, pubblicato nel 1972, promettono un contenuto denso di liaisons e un’articolazione del dibattito sui musei d’impresa che lo colloca nel più esteso ambito critico della valorizzazione della cultura materiale. Intenzioni non tradite da un testo che, prima di arrivare al vivo della trattazione nei capitoli terzo e quarto, fa tesoro della crescita degli studi in questo settore, che hanno ormai maturato trent’anni di riflessioni, iniziate con le esplorazioni storico-economiche negli archivi delle imprese negli stessi anni in cui si imparava a leggere i segni lasciati dell’operosità dell’uomo e a trattarli come veri monumenti della storia. L’argomento, come è noto, è col tempo divenuto oggetto di convegni dedicati, che sono ormai degli appuntamenti di riferimento importanti per il confronto con gli altri paesi sui temi del corporate heritage.
Titolo e sottotitolo del libro di Fiorella Bulegato, oltre a richiamare lo studio pionieristico di Ferdinando Bologna Dalle arti minori all’industrial design. Storia di un’idea, pubblicato nel 1972, promettono un contenuto denso di liaisons e un’articolazione del dibattito sui musei d’impresa che lo colloca nel più esteso ambito critico della valorizzazione della cultura materiale. Intenzioni non tradite da un testo che, prima di arrivare al vivo della trattazione nei capitoli terzo e quarto, fa tesoro della crescita degli studi in questo settore, che hanno ormai maturato trent’anni di riflessioni, iniziate con le esplorazioni storico-economiche negli archivi delle imprese negli stessi anni in cui si imparava a leggere i segni lasciati dell’operosità dell’uomo e a trattarli come veri monumenti della storia. L’argomento, come è noto, è col tempo divenuto oggetto di convegni dedicati, che sono ormai degli appuntamenti di riferimento importanti per il confronto con gli altri paesi sui temi del corporate heritage.
Il libro comprende quattro capitoli: Il museo contemporaneo e i musei d’impresa; La nascita e lo sviluppo della arti industriali in Italia a metà Ottocento; I musei d’impresa industriale contemporanei; Il museo d’impresa al servizio del progetto. E un’appendice che, a 10 anni dalle schede di Monica Amari nel suo I musei delle aziende. La cultura della tecnica tra arte e storia, censisce i principali musei, archivi e collezioni del patrimonio industriale, aggiornando la distribuzione sul territorio di questi bacini culturali.
È evidente che il nucleo della ricerca sta in quei capitoli finali dove si concentra uno sforzo analitico applicato alla classificazione dei musei d’impresa italiani e alla riflessione sui tre casi studio (Archivio-museo Alessi, Museo Ferragamo, Tif-Tipoteca italiana fondazione), ritenuti significativi per la complementarietà instaurata tra lavoro aziendale e conservazione del proprio materiale storico, e dei quali la Bulegato mette bene in luce differenze e criticità. È in questa parte, infatti, che si approfondisce l’ambito d’indagine e si dipana la classificazione proposta dall’autrice per i musei del patrimonio industriale (musei dell’industria e del lavoro; musei di distretto d’imprese ed ecomusei; musei d’impresa strettamente intesi; archivi-collezioni d’impresa; collezioni tematiche di tipologie di artefatti; archivi storici), con l’articolata tassonomia necessaria a chiarire inclusioni ed esclusioni, poggiante su quella proposta da Massimo Negri nel primo manuale dedicato all’argomento, in cui già si chiariva la necessità di evidenziare i prerequisiti di questi musei, per non fare confusione con altre modalità di comunicazione che hanno a che vedere piuttosto con le aree commercial-espositive interne alle aziende stesse.
La Bulegato tocca nel vivo le specificità dei musei d’impresa contemporanei attraverso l’analisi dei requisiti, dei caratteri peculiari, e delle strategie narrative che il racconto di una storia aziendale comporta: un racconto che, nei casi migliori, vede coprotagonisti attori quasi scomparsi dai musei “tradizionali” e ormai di rado chiamati in scena in occasioni espositive che difficilmente scaturiscono da nuove iniziative di studio: i documenti d’archivio, i progetti, il contesto culturale. Quasi che la sensibilità rivolta al come far emergere il contesto di un artefatto attraverso una molteplicità di letture possibili (morfologiche, sociologiche, antropologiche, tecniche ecc.), e la consapevolezza del problema di storicizzare il contemporaneo in continuo divenire, si fossero ormai ritagliate un ristretto campo d’azione nei musei delle aziende, in un momento attuale che vede il museo tradizionale indietreggiare di fronte a queste riflessioni e rifugiarsi in una autoreferenziale auraticità dell’oggetto esposto e dell’edificio museale stesso. In un’epoca di boom museale, in cui, come ha scritto Gregotti, il museo-supermercato ha rinunciato ormai al suo ruolo attivo, considerato un tempo il più nobile, di essere luogo di produzione e di discussione, ecco che invece il museo d’impresa diventa bacino di suggestioni per i progettisti (arrivando ad esporre persino i pezzi non entrati in produzione, come nel casi di Alessi), e avoca a sé proprio quel ruolo perduto, legando il racconto del passato alla produzione (e al consumo) nel tempo presente. Missione possibile in quanto, diversamente dai musei della scienza e della tecnica, dove evidentemente il vintage coincide con l’obsoleto e non ha futuro, i musei d’impresa possono concedersi il privilegio di rimettere in gioco le conoscenze, riportando in vita stili e modi delle produzioni passate, ricreando quella relazione virtuosa tra progettazione e consumo che i musei industriali anglosassoni avevano ben presente sin dalla loro nascita. A proposito di questo, l’heritage inteso come fonte per il progetto, viene spontaneo concludere che in un certo senso i musei d’impresa potrebbero essere considerati gli ultimi depositari dello spirito del museo illuminista e ottocentesco, votato all’educazione e al bello: pensare a giovani progettisti che si rivolgono alla tradizione per la produzione di oggi, rievoca vagamente quelle stampe dell’Ottocento in cui la passeggiata borghese nelle sale dei musei sfiorava i cavalletti degli artisti ancora per poco impegnati nella copia dei maestri del passato.
La storicizzazione e il racconto dell’evoluzione dei musei d’impresa, trattati nella prima parte del volume con pari impegno critico, offrono agli studiosi appassionati del tema riferimenti circostanziati e spunti di riflessione. Infatti, così come nei migliori casi museali la valorizzazione dell’oggetto passa attraverso la comprensione del suo rapporto con la storia, per metafora si potrebbe dire che in modo analogo la Bulegato arriva a tracciare un profilo aggiornato dei musei d’impresa italiani non senza aver prima attraversato un terreno di conoscenze storiche necessarie e allargate, percorrendo la strada già battuta dagli studi di Drugmam, Basso Peressut, Brenna, sui cosiddetti musei della cultura politecnica. Per la prima volta, infatti, in un libro sul patrimonio dell’industria, si affronta con un’ampia prospettiva storica non solo il noto tema dei musei di arti applicate in rapporto al fenomeno delle esposizioni universali, ma più significativamente le vicende dei musei artistico-industriali nell’Italia postunitaria. Dal Regio museo di Torino aperto nel 1862, cui seguirono il Museo artistico e industriale di Roma (1874) e quello napoletano fondato da Gaetano Filangieri nel 1879, al primo nucleo delle Civiche raccolte di arte applicata che a Milano trovò collocazione nel Castello sforzesco all’apertura del Museo artistico municipale.
In parallelo, è tracciata la storia dei primi musei d’impresa nell’Italia del primo Novecento, non senza un accenno alla scarsa considerazione per la cultura tecnico-scientifica, all’imprinting crociano del sistema educativo, nonché al carattere idealistico della coeva cultura museologica, circostanze culturali che portarono nel secondo dopoguerra a dividere definitivamente le strade del museo da quelle degli istituti d’arte (esemplare il caso del Museo artistico industriale di Roma e della sua involuzione dopo la riforma Gentile, fino allo smembramento delle collezioni).
Un tema che è solo accennato nel testo, e che in altre sedi ci piacerebbe vedere maggiormente esplorato, è quello della forma dei musei d’impresa, sul quale la Bulegato introduce la riflessione sulla scelta piuttosto comune, ed elementare, di usare forme architettoniche e allestitive che rimandano alla morfologia dell’oggetto esposto, o alludono alla scenario reale dell’oggetto ricreandolo nel teatro museale, come in quei musei dell’automobile che richiamano rampe di garage o circuiti di autodromi.
Nonostante il libro della Buligato non approfondisca quello che la stessa autrice avverte essere un confronto necessario, ovvero quello con il panorama museografico contemporaneo, questa lettura porta inconsapevolmente a riconsiderare alcuni comportamenti attuali. Contro ogni globalizzazione museale e la connessa perdita di identità con il territorio e la sua storia da parte dei musei tradizionali, i musei d’impresa, invece, sull’identità, la memoria e il rapporto con il territorio fanno crescere culturalmente la propria individualità. La minacciata nascita di un secondo Louvre nell’emirato di Abu Dhabi, annunciata per il 2012, è l’occasione che ha spinto Jean Clair in un recente pamphlet (Malaise dans les musées, edito in italiano da Skira), a smascherare questi cosiddetti “progetti della cultura immateriale e universale”, in cui pochi (s)fortunati musei-marchio non diventano altro che gli ambasciatori di un grande vuoto culturale. Come a dire: dagli ecomusei ai musei globali, dalla tesaurizzazione della cultura materiale alla povertà culturale delle attuali “imprese dei musei”.
In conclusione, un rammarico: in un libro uscito nel maggio 2008 e dedicato con tanto scrupolo analitico e bibliografico a questi temi, che puntualizza l’anomalia italiana di non avere avuto finora un museo nazionale del disegno industriale, si sarebbe desiderato conoscere il parere dell’autrice sul neonato Museo del design, inaugurato nel dicembre 2007 nel Palazzo della Triennale a Milano, definito da chi lo dirige un sistema mutante di museo-laboratorio, che ha la particolarità di proporre allestimenti tematici ideati per una durata “temporanea” di 12-18 mesi e si offre quale tessuto di connessione proprio per quei preesistenti giacimenti del design diffusi sul territorio, che altro non sono che le collezioni aziendali e i musei d’impresa.
|
 |
|
| |
|
 |
 |
altre recensioni |
|
|
|
|
 |
